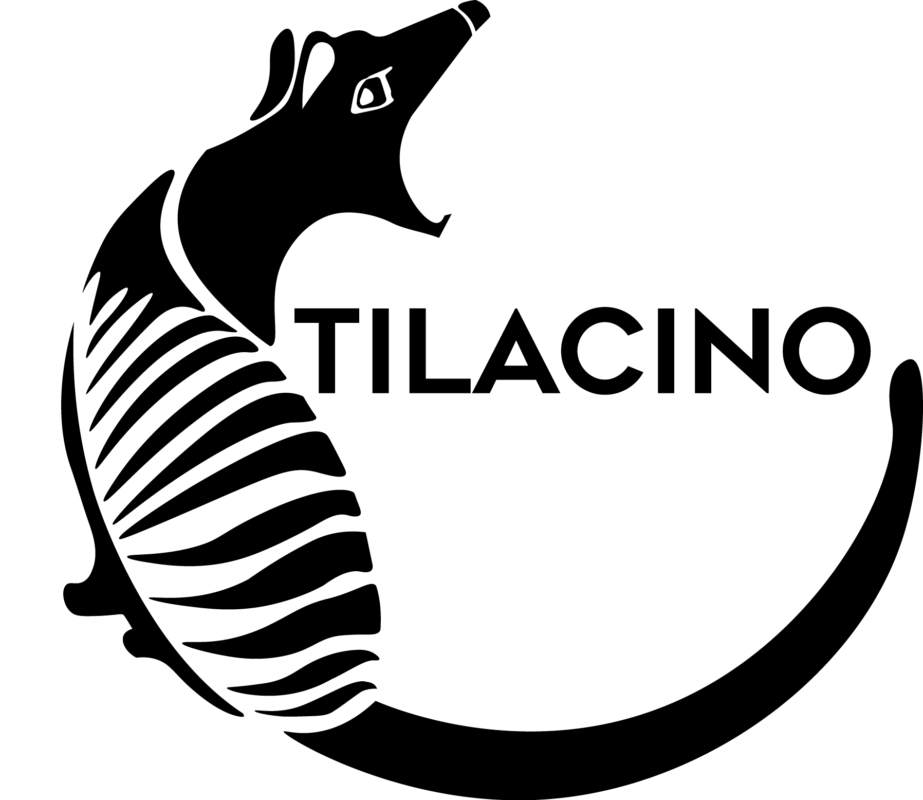BUON NATALE GENERALE GARIBALDI. IL GARIBALDINO NORDISTA WILLIAM BAILEY

Reliquia della spedizione dei Mille Garibaldi del 1860 realizzata da John Peckard per il garibaldino unionista William Bailey Bailey
Rara opera d’arte calligrafica del 1860 in onore del patriota italiano Giuseppe Garibaldi, creata e firmata da John Peckard , designer e scrittore, e donata come “reliquia” a William Bailey il 25 dicembre 1860. Cornice d’epoca originale con ritagli biografici di Garibaldi della fine del XIX secolo allegati al retro.
Si tratta di un raro e storicamente significativo ritratto a macchina incorniciato di Giuseppe Garibaldi.
L’opera è stata creata da John Peckard , designer e scrittore, e reca personalmente la seguente iscrizione:
“Presentato al signor Wm Bailey come reliquia, il 25 dicembre 1860.
L’opera d’arte raffigura Garibaldi in uniforme all’interno di una corona floreale, con la parola “PENMANSHIP” resa in modo prominente in un’elaborata calligrafia vittoriana. Sullo sfondo appare una nave, a simboleggiare le imprese navali di Garibaldi. Non si trattava di una stampa prodotta in serie, bensì di un pezzo da presentazione nella tradizione della calligrafia ornamentale del XIX secolo, probabilmente una commissione o un regalo unico nel suo genere.
La cornice è originale e sul retro e ci sono due ritagli di giornale della fine del XIX secolo che forniscono una biografia di Garibaldi — una pratica vittoriana comune per documentare l’argomento
Caratteristiche
Data: 25 dicembre 1860
Artista/calligrafo:
John Peckard o (Peckerd) , designer e scrittore
Dedica: al signor William Bailey, annotata con inchiostro sull’opera d’arte
Tecnica: inchiostro su carta, calligrafia ornamentale con ritratto e abbellimenti

L’eroe italiano GIUSEPPE GARIBALDI era una delle persone più popolari della sua epoca in Europa ed era visto come un pilastro vivente della libertà; Washington inviò un invito diplomatico per lui a portarsi negli Stati Uniti dove gli sarebbe stato riconosciuto il rango di generale dell’armata dell’Unione. Garibaldi declinò l’offerta perché non voleva il comando supremo dell’intero esercito unionista e perché gli Stati Uniti ancora non avevano formalmente abolito la schiavitù.
Dall’ambasciatore Peter Bridges
[Di seguito il testo di una lezione tenuta il 22 maggio 2013 ai docenti e agli studenti del Collegio Ghislieri dell’Università di Pavia, nel nord Italia.]
Sono profondamente onorato di essere stato invitato a parlare qui questa sera. Sono grato al Rettore Andrea Belvedere, e soprattutto alla Dott.ssa Arianna Arisi Rota, per avermi inizialmente suggerito di intervenire, per aver predisposto tutti gli accordi necessari e, non da ultimo, per avermi permesso di incontrare prima oggi i suoi colleghi e studenti. Sono altrettanto lieto che il nostro Console Generale a Milano, Kyle Scott, abbia trovato il tempo di presentarmi al termine di un’intensa giornata a Pavia.
La mia conoscenza della storia italiana presenta grandi lacune, ma ho almeno una vaga idea di quanti illustri sovrani, statisti, scienziati e scrittori abbiano frequentato le sale di questo Collegio negli ultimi cinque secoli. Spero che negli anni a venire si possano vedere qui americani più meritevoli di me.
Ciò di cui voglio parlare stasera è il rapporto tra i nostri due Paesi, Italia e Stati Uniti, e in particolare come – e perché – tale rapporto si è sviluppato nel XIX secolo. Almeno due personaggi che hanno visitato questo onorevole Collegio, Giuseppe Garibaldi e Vittorio Emanuele II, hanno avuto un ruolo in tale rapporto, e di cui parlerò più avanti.
Un elemento fondamentale nella storia dello sviluppo delle nostre relazioni bilaterali è certamente il contrasto.
Dalla nostra parte dell’Oceano Atlantico si trovava una repubblica che nel 1860, quando aveva meno di un secolo di vita, iniziò a dividersi in due, seguita di lì a poco da una sanguinosa guerra civile. L’Italia, al contrario, era un Paese che era diventato repubblica cinque secoli prima di Cristo e che finalmente nel 1860 vide la maggior parte del suo territorio unito per la prima volta dopo molti secoli.
In America la democrazia era fiorente, fatta eccezione per i quattro milioni di schiavi neri che costituivano più del 12 percento della popolazione totale.
In Italia esisteva la monarchia e non la democrazia, ma Vittorio Emanuele II mantenne almeno la costituzione, lo Statuto Albertino del 1848, sebbene altrove in Europa i governi fossero autocratici e tirannici.
Nei primi decenni del XIX secolo non ci furono molti contatti tra America e Italia. Non furono gli italiani, ma olandesi, inglesi, francesi, spagnoli e svedesi a colonizzare il Nord America sulla scia di Cristoforo Colombo e Giovanni da Verrazzano. Tuttavia, un membro di una famiglia genovese fu tra i primi coloni in Virginia: Albiano Lupo arrivò a Jamestown nel 1610, diversi decenni prima che due dei miei antenati giungessero in Virginia dall’Inghilterra. Oggi ci sono membri della famiglia di Albiano Lupo in America, tra cui il mio amico ed ex collega Samuel Lupo, che ha prestato servizio come ambasciatore americano alcuni anni fa.
Non molti italiani seguirono Albiano Lupo in America nei due secoli successivi. Alcuni di coloro che arrivarono ebbero un ruolo positivo nella nostra storia iniziale. Diversi italiani provenienti dalla Virginia e da altre colonie combatterono nella nostra guerra d’indipendenza dall’Inghilterra, iniziata nel 1775. Prima della guerra, Thomas Jefferson, il principale autore della nostra Dichiarazione d’Indipendenza e il nostro terzo Presidente, aveva un vicino e amico in Virginia di nome Filippo Mazzei. Mazzei era originario della Toscana e tentò, senza successo, di introdurre la viticoltura in Virginia. Durante la Guerra d’Indipendenza, Jefferson inviò Mazzei in Italia e altrove in Europa come inviato del nuovo Stato della Virginia.
Lo stesso Jefferson fu uno dei primi visitatori americani in Italia. Nel 1787, quando era nostro inviato in Francia, Jefferson compì una lunga visita in Piemonte, Lombardia e Liguria. Sognava di visitare l’Italia fin da ragazzo. Il suo viaggio aveva ora uno scopo serio: ridurre la dipendenza economica dell’America da Gran Bretagna e Francia, incoraggiando lo sviluppo del commercio americano con il Regno di Sardegna. Aveva anche un motivo segreto per visitare il Piemonte. Il riso veniva coltivato in diversi stati del Sud, ma la qualità era inferiore a quella del riso piemontese. Le leggi del Piemonte, tuttavia, proteggevano il suo riso; la pena per l’esportazione di semi di riso dal Piemonte era la morte. Jefferson non si lasciò scoraggiare; riempì le tasche del suo cappotto di semi di riso piemontese e li riportò illegalmente in Francia. Viene da chiedersi cosa sarebbe successo se le guardie doganali piemontesi avessero scoperto cosa trasportava.
Nel frattempo, alcuni italiani si stavano recando in America. Come è noto, Giuseppe Garibaldi trovò rifugio a New York per diversi mesi, dopo la caduta della Repubblica Romana nel 1849. Tuttavia, quando Garibaldi giunse a New York, in città c’erano al massimo diverse centinaia di italiani. Il censimento statunitense del 1850 mostrava solo 3.645 italiani tra gli oltre due milioni di americani nati all’estero. (La maggior parte dei nuovi americani proveniva da Gran Bretagna, Germania e, più recentemente, Irlanda.)
Garibaldi lasciò gli Stati Uniti nel 1851, ma questo non pose fine al suo interesse per l’America. È stata raccontata più volte la storia di come, dopo lo scoppio della guerra civile americana, si offrì gentilmente di diventare comandante in capo delle nostre forze del Nord. Garibaldi avrebbe potuto fare meglio di alcuni dei generali impiegati da Abraham Lincoln; Garibaldi sapeva combattere e guidare gli uomini. Ma era anche un uomo che si considerava alla pari di monarchi e capi di governo, e si sospetta che il suo rapporto con il presidente Lincoln si sarebbe rivelato difficile quanto quello di Lincoln con altri generali come George McClellan, che fu comandante in capo di Lincoln per troppo tempo. Alla fine, Lincoln offrì a Garibaldi un incarico come maggiore generale, e Garibaldi lo rifiutò, il che fu forse una fortuna.
Sebbene Garibaldi alla fine non combatté nella nostra Guerra Civile, diversi altri italiani lo fecero. A New York City fu formato un reggimento chiamato Garibaldi Guard; molti dei suoi membri avevano combattuto con Garibaldi in Italia. Un italoamericano di nome Francesco Spinola formò quattro reggimenti per l’esercito dell’Unione e combatté eroicamente durante la guerra. Molto più tardi, nel 1887, Spinola fu il primo italoamericano eletto al Congresso degli Stati Uniti. Ma la figura più eroica tra gli italiani in guerra fu il conte Luigi Palma di Cesnola, che era stato un ufficiale di cavalleria piemontese e il cui coraggio come comandante di cavalleria nella guerra americana è stato descritto da numerosi storici.
Ciò che è meno noto su Giuseppe Garibaldi e l’America è che nella primavera del 1860, prima di salpare per la Sicilia per attaccare l’esercito borbonico con i Mille, Garibaldi fece visita privatamente all’inviato americano a Torino, John Moncure Daniel. Garibaldi era irritato dal fatto che Vittorio Emanuele II fosse disposto a cedere la sua città natale, Nizza, e in effetti tutta la Savoia, la patria del re, alla Francia, in cambio della promessa di Napoleone III di inviare un esercito francese per aiutare a liberare gli italiani rimasti sotto il dominio austriaco.
Garibaldi chiese a Daniel se gli Stati Uniti avrebbero fornito assistenza o protezione a Nizza nel caso in cui la città avesse dichiarato l’indipendenza sia dalla Francia che dall’allora Regno di Sardegna. Questo è il tipo di domanda che, se posta oggi a un inviato diplomatico, l’inviato si rivolgerebbe immediatamente al proprio governo tramite telegramma. Nel 1860, tuttavia, non esisteva un telegrafo transatlantico e ci sarebbero volute settimane prima che Daniel riferisse dell’arrivo di Garibaldi e ricevesse istruzioni da Washington. Daniel rispose quindi immediatamente a Garibaldi che la politica americana era quella di riconoscere tutti i governi che fossero riusciti a imporsi e che potessero essere considerati organizzazioni responsabili. Non pensava che Nizza avrebbe avuto alcuna possibilità di affermare la propria indipendenza.
Garibaldi disse che quella era la risposta che si aspettava, ma che aveva ritenuto importante esplorare tutte le possibilità di assistenza per Nizza. Ora rivolse la sua attenzione altrove. Meno di un mese dopo, il 5 maggio, salpò per la Sicilia con i suoi Mille (che includevano diversi volontari americani). Si può solo immaginare cosa sarebbe potuto accadere se Daniel avesse incoraggiato Garibaldi a credere che l’America avrebbe potuto contribuire a difendere una Nizza in rivolta.
Come accennato, al tempo del soggiorno di Garibaldi a New York c’erano relativamente pochi italiani negli Stati Uniti. Gli italiani, tuttavia, stavano iniziando ad arrivare, e un primo impulso fu la scoperta dell’oro in California nel 1848. La “corsa all’oro” portò almeno trecentomila persone in California, tra cui diversi italiani. I documenti dell’Archivio Storico Diplomatico, presso il Ministero degli Affari Esteri a Roma, contengono un elenco risalente al 1850 con i nomi di diverse centinaia di italiani in California che avevano contribuito a un fondo per le famiglie dei soldati piemontesi caduti o feriti nella recente guerra con l’Austria. I contribuenti erano elencati in base al luogo in cui vivevano, alcuni nella città di San Francisco, ma molti in piccoli campi minerari oggi scomparsi. Fu l’inizio della comunità italiana in California che per oltre un secolo e mezzo ha contribuito così tanto alla cultura e alla prosperità di quel grande stato.
Sembra che persino Vittorio Emanuele II abbia accarezzato l’idea di trasferirsi in America. Uno dei suoi primi biografi riferisce che, in seguito alla sconfitta italiana contro gli austriaci a Novara, nel 1849, il nuovo re comunicò al suo primo ministro, Massimo d’Azeglio, che gli austriaci lo stavano pressando affinché revocasse lo Statuto e che, piuttosto che farlo, si sarebbe recato in America. Il re era un grande cacciatore e senza dubbio avrebbe trovato la caccia piacevole in America, anche se qui manca la sua preda preferita, lo stambecco.
Torniamo ora indietro nel tempo, ai primi anni dell’indipendenza americana, per considerare il rapporto governativo, o meglio i rapporti, che iniziarono a svilupparsi tra noi.
Durante i nostri primi decenni come repubblica indipendente, gli americani erano diffidenti nei confronti del mondo straniero. Avevamo ragione di esserlo. In Europa, i governi erano decisamente antidemocratici e non volevano vedere l’esperimento americano di governo ripetuto nei loro paesi. Erano felici di vedere i loro rivoluzionari repubblicani rifugiarsi negli Stati Uniti. Anzi, a volte li aiutavano a farlo. Negli anni ’50 dell’Ottocento, come si può leggere negli archivi di Roma, il governo del Regno di Sardegna imbarcò diverse decine di attivisti politici su fregate navali che li trasportarono attraverso l’Atlantico e li sbarcarono a Boston e a New York.
A causa di questa diffidenza americana nei confronti del mondo straniero, mantenemmo – o cercammo di mantenere – un livello relativamente basso di attività diplomatica in altri Paesi. Fino al 1893 non esistevano ambasciatori o ambasciate americane. Le nostre sedi diplomatiche erano legazioni, guidate non da ambasciatori ma da inviati con il grado di ministro e talvolta solo quello di incaricato d’affari.
C’era forse una certa dose di autoinganno in tutto questo. Se non politicamente o strategicamente, l’America era fortemente coinvolta con il resto del mondo nel commercio e negli scambi commerciali, e nel corso del nostro primo secolo di indipendenza aprimmo molti consolati in città straniere per assistere i mercanti e le spedizioni americane. Nel 1860 c’erano solo 47 legazioni americane, ma c’erano consoli americani in 305 città straniere, dieci delle quali in Italia.
Finché l’Italia rimase politicamente divisa, le nostre sedi diplomatiche e consolari furono ovviamente accreditate presso i diversi governi di questa penisola. La prima sede diplomatica o consolare americana sul suolo italiano fu il consolato americano aperto nel 1796 a Napoli, allora capitale del Regno delle Due Sicilie. Il nostro consolato a Genova, il principale porto del Regno di Sardegna, aprì due anni dopo, nel 1798. Ben presto, le navi mercantili americane trasportarono in Italia una quantità crescente di esportazioni americane.
Inviammo il nostro primo agente diplomatico nel Regno di Sardegna nel 1840. Era un oscuro gentiluomo della Pennsylvania di nome Hezekiah Gold Rogers. Il nostro primo inviato presso la Santa Sede, Jacob Martin, arrivò a Roma nell’agosto del 1848, ma morì pochi giorni dopo il suo arrivo e quindi non vide la nascita della Repubblica Romana.
Gli italiani furono un po’ più lenti nell’inviare agenti diplomatici e consolari in America. Solo nel 1817 il Regno di Sardegna aprì la sua prima sede diplomatica negli Stati Uniti: un consolato a Savannah, in Georgia, un importante porto marittimo allora come oggi.
Purtroppo, il nostro Paese non è sempre stato così attento come avrebbe dovuto nella scelta dei suoi inviati all’estero. Per quanto riguarda l’Italia, parlo ovviamente solo dei secoli passati. Il signor Rogers, il nostro primo inviato nel Regno di Sardegna, fu dichiarato malato di mente subito dopo il suo arrivo a Torino nel 1840 e fu affidato alle cure dell’infermiera capo del manicomio torinese. A peggiorare le cose, il nuovo console americano a Genova, John Bailey, si rivelò un noto fallito. Il Ministero degli Esteri sardo incaricò il suo incaricato d’affari a Washington, il conte Augusto Avogadro di Collobiano, di chiarire al Dipartimento di Stato che il governo del Regno riteneva sbagliato lasciare gli interessi americani in Piemonte nelle mani di un pazzo e di un fallito. Il nostro governo acconsentì, ma passò del tempo prima che i due uomini venissero rimossi dall’incarico.
In quegli anni c’era quasi sempre una differenza significativa tra il background dei diplomatici americani e quello dei loro omologhi europei, e non mi riferisco alla salute mentale o finanziaria.
Alcuni stati europei fecero i primi passi nella formazione dei giovani per la diplomazia. Un’opera su questo argomento del Dott. Arisi Rota osserva che Federico II di Prussia aprì una scuola per formare diplomatici già nel 1747. Un decreto reale del Regno di Sardegna del 1849 istituì un esame rigoroso per coloro che aspiravano a raggiungere i livelli più alti della diplomazia piemontese. Ma restava il fatto che gli inviati europei erano per lo più membri della nobiltà come Collobiano, la cui famiglia era tra i maggiori proprietari terrieri del Piemonte.
Gli inviati americani non erano nobili, sebbene in alcuni casi fossero anch’essi ricchi. La maggior parte di loro proveniva da quello che si potrebbe definire un ambiente pratico. Spesso erano stati banchieri, uomini d’affari o governatori di stati americani. Pochi di loro parlavano francese, la lingua della diplomazia. (Il francese era la lingua che il ministero di Torino usava per comunicare con i propri inviati, fino alla metà del XIX secolo). Ma i diplomatici americani probabilmente tendevano ad avere una migliore comprensione del proprio Paese e della sua economia, ed erano meglio attrezzati a promuovere gli interessi del proprio Paese all’estero, rispetto a un conte o un duca europeo la cui formazione si basava in gran parte sulla buona società.
Non bisogna esagerare l’importanza dei rapporti ufficiali, negli anni precedenti al 1860, tra il nostro governo e quelli del Regno Sabaudo, dello Stato Pontificio e del Regno delle Due Sicilie. Furono Francia, Austria e Gran Bretagna a contare di più, politicamente e strategicamente, per gli italiani in quegli anni. Ciononostante, il commercio con l’America stava diventando importante. Nel 1856 la nostra legazione a Torino riferì a Washington che gli Stati Uniti erano diventati il terzo partner commerciale del Regno di Sardegna, dopo Francia e Gran Bretagna.
C’era anche la questione dei contatti umani non ufficiali. Ralph Waldo Emerson disse nel 1843 che “andiamo a scuola in Europa”. Ciò era vero fin dall’inizio della repubblica americana e nel 1843 – e anche in seguito – rimase vero, per diversi motivi. Gli americani dipendevano ancora fortemente dal patrimonio culturale europeo. Per essere ben istruito, un americano doveva conoscere non solo Shakespeare e Goethe, ma anche Cesare, Dante e, ovviamente, Manzoni. (La prima traduzione americana de I Promessi Sposi apparve a New York già nel 1834). Inoltre, diversi americani studiavano nelle università europee e gli americani benestanti amavano viaggiare in Europa, inclusa ovviamente l’Italia.
Altrettanto importante, per gli americani più che per gli italiani, fu il numero di artisti e scrittori americani che giunsero in Italia per studiare e lavorare. L’enorme statua in bronzo della Libertà che oggi si erge sulla cima del Campidoglio a Washington fu opera di Thomas Crawford, che trascorse a Roma tutta la sua vita come artista. Forse lo scultore americano più noto del XIX secolo fu Hiram Powers, che visse e lavorò a Firenze dal 1837 fino alla sua morte nel 1873. E non tutti questi artisti erano uomini: diverse scultrici americane lavorarono a Roma nel XIX secolo.
Per quanto riguarda la letteratura, alcuni dei grandi romanzi americani del XIX secolo sono ambientati in Italia e sono opera di autori che vissero, o almeno viaggiarono molto, in Italia. Si pensi, ad esempio, a Il fauno di marmo di Nathaniel Hawthorne e a romanzi di Henry James come Daisy Miller e Ritratto di signora . Un americano di nome Francis Marion Crawford, nato a Bagni di Lucca e morto a Sorrento, scrisse molti romanzi ambientati in Italia. Crawford è oggi quasi dimenticato e i suoi romanzi forse non sono grandi opere d’arte, ma per un certo periodo lo resero l’autore più venduto negli Stati Uniti. Queste opere contribuirono notevolmente a instillare pensieri sull’Italia nella mente dei lettori americani.
Crawford amava ritrarre la nobiltà. Altri scrittori americani – e la stampa americana – speravano di vedere un progresso politico in Italia. Poco dopo che le truppe del Regno posero fine al dominio papale nel 1870, il New York Times scrisse che “…sotto una monarchia limitata, l’Italia potrebbe raggiungere una prosperità e una libertà che non ha mai conosciuto sotto l’Impero Romano, o sotto i tempestosi dissensi del Medioevo, o sotto i governi degradanti dei tempi moderni”.
Alcune opere americane furono ampiamente lette in Italia. Si dice che tutto ciò che molti italiani nel XIX secolo sapevano, o pensavano di sapere, sull’America fosse ciò che leggevano nei romanzi di James Fenimore Cooper. Il romanzo americano che ebbe forse il più grande successo in Italia fu ” La capanna dello zio Tom” , la drammatica descrizione dei mali della schiavitù in America scritta da Harriet Beecher Stowe. Il libro fu pubblicato in America nel 1852 e lo stesso anno apparvero edizioni italiane sia a Milano che a Torino. Nel giro di due anni ne furono pubblicate nove.
Sempre per quanto riguarda gli spostamenti di persone, è vero che durante l’ Ottocento giunsero in Italia più intellettuali americani che italiani in America. Tuttavia, un interessante veneto giunse in America nel 1805 dopo aver scritto i libretti per più di due dozzine di opere, tra cui il Don Giovanni e Così fan tutte di Mozart. Si trattava di Lorenzo Da Ponte, che divenne il primo professore di letteratura italiana al Columbia College – oggi Columbia University di New York – e che aprì a New York un teatro d’opera che fu il predecessore dell’attuale Metropolitan Opera.
Oltre al campo dell’attività artistica, sia i rivoluzionari repubblicani italiani che giunsero in America sia gli americani che scrivevano a casa dall’Italia contribuirono ad accrescere la consapevolezza americana di ciò che stava accadendo – o non accadendo – in Italia. La Giovine Italia , la cui creazione Mazzini annunciò nel 1831, fu imitata nel nostro paese dalla creazione nel 1845 della Young America, che per qualche tempo svolse un ruolo importante nell’ala sinistra del Partito Democratico americano. Margaret Fuller, la famosa autrice dell’opera ” La donna nel diciannovesimo secolo” , divenne ancora più famosa per i suoi resoconti di prima mano sul New York Tribune sulla Repubblica Romana e la sua caduta nel 1849.
Tornando alla questione dei rapporti ufficiali, vorrei menzionare due inviati americani in Italia che mi hanno particolarmente interessato. Il servizio di questi due uomini in Italia durò quasi tre decenni, dal 1853 al 1882. Entrambi erano individui di eccezionale capacità, ma avevano visioni totalmente diverse della politica e della società americana.
Questi due uomini erano John Moncure Daniel, menzionato in precedenza, e il suo successore, George Perkins Marsh. Daniel era un sudista, un razzista pro-schiavitù originario della Virginia, che tornò dall’Italia in Virginia allo scoppio della Guerra Civile nel 1861 e che durante quella guerra divenne il direttore di giornale più influente della Confederazione del Sud. Marsh, d’altra parte, era un abolizionista, un forte oppositore della schiavitù, originario dello stato settentrionale del Vermont, che Lincoln inviò nel 1861 come nostro primo ministro nel nuovo Regno d’Italia e che rimase come nostro inviato in Italia per 21 anni, fino alla sua morte nel 1882 all’età di ottantuno anni. (Questo, tra l’altro, rimane ancora oggi il record di longevità per qualsiasi capo di una missione diplomatica americana.)
John Daniel arrivò a Torino nel 1853, accreditato presso quello che non era ancora il Regno d’Italia, bensì quello di Sardegna. Aveva solo 28 anni: uno dei due più giovani ad essere mai diventati capi missione americani. Daniel era stato, come sarebbe stato in seguito, direttore di un giornale di Richmond che sosteneva il Partito Democratico. Si recò a Torino per un incarico politico, come tutti i nostri incarichi diplomatici a quell’epoca. Aveva lavorato duramente nella campagna elettorale presidenziale del 1852 per assicurarsi il sostegno degli elettori in Virginia per Franklin Pierce, il candidato del Partito Democratico. Pierce fu eletto Presidente e Daniel ottenne la sua legazione.
Quando Daniel arrivò a Piedmont, non aveva intenzione di rimanerci per più di un anno. Voleva tornare in Virginia per le elezioni del Congresso del 1854, in cui sperava che il suo giornale avrebbe svolto un ruolo importante, sia a livello nazionale che locale. Poco dopo il suo arrivo a Turin, divenne il centro di uno scandalo che avrebbe potuto portare alla sua partenza non in un anno o due, ma nel giro di pochi giorni.
La fonte dello scandalo fu una lettera privata che il nostro nuovo inviato scrisse a un intimo amico a Richmond. Sottolineò all’amico che quanto scritto era strettamente confidenziale e che l’amico non avrebbe dovuto condividere la lettera con nessun altro. Daniel non era sposato e si sentiva solo; ma scrisse che le giovani donne del Piemonte non erano minimamente belle come le ragazze della Virginia. Peggio ancora, disse, tutti a Torino puzzavano d’aglio e i diplomatici e i funzionari con cui si incontrava avevano titoli nobiliari lunghi quanto il suo braccio, ma teste completamente vuote.
Sfortunatamente per John Daniel, il testo completo della sua lettera “riservata” apparve presto sui giornali di Richmond, New York e Torino. Ci fu ovviamente una forte reazione. Dava per scontato che sarebbe stato sfidato a duello, ed era pronto a combattere; aveva combattuto diversi duelli in America. Ma nessuno lo sfidò. Si offrì di dimettersi dal suo incarico, ma il presidente Pierce a Washington non lo ritenne necessario. Il ministro degli Esteri a Torino, l’ex generale Giuseppe Dabormida, fu sorpreso quando Daniel non si dimise, ma non chiese la partenza dell’americano, come avrebbe potuto benissimo fare.
Successivamente Daniel si dimenticò di tornare in Virginia per le elezioni americane. Rimase a Torino per più di sette anni, anni di notevoli sviluppi sia in America che in Italia. Acquisì una buona conoscenza della lingua italiana e strinse numerose amicizie altolocate, tra cui una signora che a volte veniva chiamata, alle sue spalle, la Principessa Brouhaha. Si trattava di Marie, Contessa di Solms, pronipote di Napoleone I e quindi cugina di Luigi Napoleone, che si era da poco fatto imperatore con il nome di Napoleone III e che l’aveva espulsa dalla Francia per aver criticato il suo regime. In Piemonte, si sussurrava, tra gli amici altolocati e le amicizie della principessa c’erano anche il Re e il suo letto.
Si sussurrava, tra l’altro, che Vittorio Emanuele II si fosse stancato della signora e che lei fosse poi diventata buona amica di Umberto Rattazzi. Infatti sposò Rattazzi. Ciò non le impedì di pubblicare, quando Rattazzi era Primo Ministro e Firenze era diventata la capitale nazionale, un romanzo intitolato Bicheville , un ritratto satirico e appena camuffato di Firenze e della società fiorentina. Uno dei risultati fu che Rattazzi fu sfidato a duello. Lui non accettò. Dopotutto era il Primo Ministro. Ma voi, come italiani, senza dubbio ne sapete molto di più su queste cose di quanto qualsiasi americano possa mai sperare di imparare.
In ogni caso dobbiamo tornare al nostro argomento, che sono le relazioni italo-americane e non chi dormiva nel letto di chi, anche se, a dire il vero, col passare degli anni c’era chi diceva che, di fatto, l’Italia era diventata un satellite, se non un succubo, della Francia.
Non si dovrebbero ignorare i rapporti tra America e Stato Pontificio. Sebbene una legazione americana fosse stata aperta a Roma nel 1848, nessun delegato apostolico fu inviato negli Stati Uniti fino al 1893. Tuttavia, nel 1853 Pio IX inviò il vescovo Gaetano Bedini, che era stato governatore pontificio di Bologna nel 1849, negli Stati Uniti per una visita che durò sette mesi. La visita fu un disastro. Bedini fu definito il “macellaio di Bologna” a causa del massacro avvenuto lì quando era governatore. Si sosteneva che progettasse segretamente di instaurare una sorta di dittatura papale negli Stati Uniti. Ci furono rivolte e un tentativo di assassinarlo, e il risultato della visita fu di accrescere ulteriormente il sentimento anticattolico che si stava sviluppando negli Stati Uniti.
Nel frattempo, a Torino, John Moncure Daniel trovò nel Regno di Sardegna – come si legge sia nei suoi rapporti ufficiali che nelle sue lettere personali – diversi aspetti da apprezzare. Riferì a Washington in modo approfondito sull’esercito sardo, che trovò ben addestrato e ben equipaggiato e che, con cinquantamila uomini, era di gran lunga più numeroso di quello americano. In ambito navale, il governo del Regno permise alla Marina statunitense di stabilire a La Spezia il deposito per la nostra squadra del Mediterraneo.
Daniel, il diplomatico, non era mai stato un soldato, ma pare fosse un buon osservatore di soldati. Riferì a Washington, subito dopo che Garibaldi era salpato da Genova con la sua piccola spedizione dei Mille, che se Garibaldi fosse riuscito a sbarcare in Sicilia, avrebbe indubbiamente ottenuto la vittoria. C’è da dubitare che qualche altro osservatore straniero in Italia a quel tempo fosse così sicuro dell’esito del Mezzogiorno .
Nel frattempo, dall’altra parte dell’Atlantico, una grande crisi incombeva sugli Stati Uniti. Il Presidente che entrò in carica nel 1857 era James Buchanan. Aveva ricoperto la carica di ministro americano a Londra e di Segretario di Stato, ma era un leader mediocre. Se un leader migliore avrebbe potuto prevenire il conflitto tra Nord e Sud rimane una questione molto dibattuta; ma è chiaro che Buchanan non fece nulla per risolvere i problemi.
Probabilmente pochi americani credevano che la guerra sarebbe scoppiata, anche se gli stati del Sud avessero lasciato l’Unione. Di certo, pochi osservatori stranieri avevano previsto la guerra. Il ministro italiano negli Stati Uniti, il conte Giuseppe Bertinatti, incontrò a un certo punto una ricca vedova americana, che in seguito sposò. Aveva ereditato dal primo marito una grande piantagione e diversi schiavi nel Mississippi, e si presume che questo abbia avuto un ruolo nella formazione delle opinioni di Bertinatti sulla scena americana. Tuttavia, Bertinatti rimase a Washington durante la guerra, e i suoi resoconti al ministero furono basati sui fatti e i suoi rapporti con l’amministrazione di Abraham Lincoln sembrano essere stati cordiali. Infatti, William Seward, Segretario di Stato di Lincoln, scrisse al Presidente che Bertinatti era “un caro amico”. Quando nel 1864, quarto anno di guerra, Bertinatti ricevette una promozione, Lincoln lo invitò alla Casa Bianca per porgergli le sue congratulazioni. Lincoln disse a Bertinatti che, nonostante ci fossero state divergenze durante la guerra tra gli Stati Uniti e alcuni governi, “…in nessuna fase di questa infelice guerra fraterna, il Re o il popolo italiano hanno esitato nel rivolgerci il linguaggio del rispetto, della fiducia e dell’amicizia”.
Lincoln arrivò tardi alla carriera di statista. Figlio di una famiglia molto povera, si formò quasi completamente da autodidatta. Studiò legge e divenne avvocato. Durante la Guerra Civile, trascorreva le serate a leggere di questioni militari, poiché si rese conto che, in qualità di comandante in capo, ne sapeva molto meno del dovuto su eserciti e guerra. Lesse Shakespeare e gli piaceva recitare a memoria passi di Amleto e Macbeth . Ciò che leggeva sull’Europa moderna sembrava essere principalmente resoconti pubblicati sulla stampa. Lincoln era, tuttavia, un politico esperto e imparò da solo a essere un buon diplomatico. Trattò con saggezza, e spesso con senso dell’umorismo, i governi europei e i loro inviati a Washington, incluso il ministro italiano.
Alla vigilia del conflitto in America, quando era alla Casa Bianca da meno di un mese, Lincoln aveva compiuto un passo che ebbe un’influenza positiva sull’atteggiamento degli italiani nei confronti degli Stati Uniti. Il 13 aprile 1861, informò Bertinatti che gli Stati Uniti avevano ufficialmente riconosciuto la costituzione, avvenuta il mese precedente, del nuovo Regno d’Italia. Solo due mesi dopo, a giugno, la Francia, grande amica dell’Italia, seguì l’esempio. Il rapido riconoscimento del nuovo Regno da parte degli Stati Uniti fu ben accolto a Torino.
Torniamo al 1860, prima che Lincoln andasse alla Casa Bianca. John Daniel era stato il nostro inviato in Italia per sette anni. L’estinzione dello Stato Pontificio e del Regno delle Due Sicilie significò la chiusura delle legazioni americane a Roma e Napoli. Daniel si ritrovò ora a capo dell’unica missione diplomatica americana in Italia. Si era guadagnato un’eccellente reputazione a Washington, come analista degli eventi sia in Italia che altrove in Europa. Sperava di essere presto confermato Ministro del Regno d’Italia. Ma poi, nel dicembre 1860, lo Stato della Carolina del Sud si separò dall’Unione Americana e altri stati del Sud seguirono l’esempio. La nostra Unione si stava dividendo in due proprio mentre l’Italia si unificava. Daniel pensò che fosse giunto il momento di tornare in Virginia, e lo fece rapidamente. Svolse un ruolo significativo come redattore a Richmond, capitale della nuova Confederazione, fino al 1865, quando morì all’età di 39 anni, proprio alla fine della guerra.
Durante la nostra Guerra Civile, il principale problema diplomatico per Lincoln e la sua amministrazione fu che i governi europei potessero riconoscere ufficialmente e fornire assistenza alla Confederazione del Sud. Gli inglesi ci andarono vicino. Riconobbero la Confederazione come un belligerante legittimo e per un certo periodo permisero la costruzione nei cantieri navali britannici di navi per la marina confederata. La più nota di queste navi fu l’ Alabama , che fu completata nel 1862 e che nei due anni successivi catturò o distrusse 65 navi mercantili del Nord. Il governo britannico proibì infine la costruzione di ulteriori navi per il Sud dopo che l’inviato americano a Londra suggerì la possibilità che l’America potesse entrare in guerra con la Gran Bretagna.
Anche la Francia adottò un atteggiamento ostile nei confronti dell’Unione Americana. Diversi decenni prima, nel 1823, il presidente statunitense James Monroe, in quella che sarebbe diventata nota come Dottrina Monroe, aveva avvertito che, sebbene gli Stati Uniti non avrebbero interferito con le colonie europee esistenti nell’emisfero occidentale, non avrebbero tollerato alcun tentativo da parte di una potenza europea di interferire con una qualsiasi repubblica americana indipendente.
Ora, però, la nostra Unione era alle prese con la guerra civile – e Napoleone III voleva creare un nuovo impero americano per la Francia – e il governo messicano creò un pretesto per l’intervento europeo quando, nel 1861, smise di pagare gli interessi sui suoi debiti esteri. Britannici, francesi e spagnoli inviarono contingenti di truppe in Messico.
Al Primo Ministro Rattazzi fu chiesto in Parlamento se anche l’Italia avrebbe inviato truppe. Diede una risposta vaga, affermando che l’Italia avrebbe agito secondo il suo interesse nazionale. Gli inglesi e gli spagnoli ritirarono presto i loro piccoli contingenti di truppe, e l’Italia non ne inviò nessuno. I francesi rimasero, presero il governo messicano e crearono un “impero” sotto Massimiliano, un principe asburgico. Quando la nostra guerra civile finì, gli Stati Uniti fecero pressione sulla Francia affinché ritirasse le sue truppe, l’impero messicano crollò e nel 1867 Massimiliano finì davanti a un plotone di esecuzione messicano. L’Italia, fortunatamente per i suoi rapporti con gli Stati Uniti, e nonostante i suoi stretti rapporti con la Francia, non aveva avuto alcun ruolo nell’avventura messicana.
Passiamo ora alla figura di George Perkins Marsh, che come nostro nuovo inviato era arrivato a Torino nel 1861 e che si sarebbe poi trasferito, insieme al governo, a Firenze e poi a Roma, nel corso dei suoi ventuno anni di servizio in Italia.
Marsh non era un neofita della diplomazia quando arrivò a Torino. In precedenza aveva prestato servizio, con grande merito, come nostro inviato presso l’Impero Ottomano. Era stato un membro influente del Congresso degli Stati Uniti. Era anche uno studioso e scrittore, che nel 1864, quando era a Torino, pubblicò in America la prima grande opera sull’ambiente di un autore americano: ” Man and Nature” . Ho scritto un breve saggio su Marsh, ma se volete saperne di più sull’uomo dovreste leggere la magnifica biografia scritta da David Lowenthal, uno studioso che credo sia molto noto in questo paese, pubblicata negli Stati Uniti alcuni anni fa.
Durante la nostra Guerra Civile, non ci fu mai un momento, a mia conoscenza, in cui il governo del Regno d’Italia prese in considerazione l’idea di riconoscere ufficialmente i nostri ribelli del Sud, gli Stati Confederati d’America. Tuttavia, come commentò uno storico americano alcuni anni fa, nella classe politica italiana c’era più simpatia per il Sud di quanto si possa immaginare. Inoltre, come commentò Marsh in un rapporto confidenziale a Washington, il Primo Ministro Umberto Rattazzi era fortemente influenzato da Napoleone III.
Alla fine, né la Francia né la Gran Bretagna, né alcun altro governo in Europa, riconobbero il governo della Confederazione. Tuttavia, nei primi anni della nostra guerra, il Nord subì una serie di gravi sconfitte sul campo di battaglia. Queste sconfitte spinsero i leader europei a chiedersi se, qualora la vittoria finale del Nord fosse stata impossibile, avrebbero dovuto riconoscere il Sud. Se la Francia lo avesse fatto, si potrebbe sospettare che l’Italia avrebbe seguito il suo esempio.
Forse nella Roma papale c’era una tentazione ancora più forte di estendere il riconoscimento diplomatico alla Confederazione. C’era chi, nella Curia, vedeva un certo parallelismo tra gli sforzi dello Stato Pontificio per mantenere la propria indipendenza di fronte agli attacchi del Nord e la lotta dei nostri stati del Sud per fare lo stesso.
Anche la personalità di Pio IX, a quanto pare, ebbe un ruolo. Il Papa aveva perso quasi tutto il suo regno terreno e il suo regime sempre più reazionario danneggiò gravemente la sua reputazione mondana. Sognava, si dice, di riconquistare la sua reputazione agendo da mediatore tra il Nord e il Sud in America. Ciò avrebbe significato almeno il riconoscimento implicito del Sud come stato indipendente, e Lincoln non poté mai accettare una cosa del genere.
Tuttavia, quando nel 1863 Jefferson Davis, il presidente confederato, inviò una lettera a Pio IX, il Papa rispose con una lettera indirizzata “all’Onorevole Presidente degli Stati Confederati d’America”. Ciò sembrò equivalere al riconoscimento ufficiale della Confederazione come governo legittimo. In seguito, quando il ministro degli Stati Uniti a Roma, Rufus King, visitò il cardinale Giacomo Antonelli, segretario di Stato pontificio, Antonelli gli confermò che il Papa aveva scritto a Davis semplicemente per esprimere il suo desiderio di pace in America. Antonelli disse a King che la lettera, per citare il rapporto del nostro inviato a Washington, “era un semplice atto di cortesia e privo di qualsiasi intenzione politica”.
Quando la Guerra Civile si concluse nel 1865 con la sconfitta del Sud, il Nord e il Sud insieme avevano perso più di 600.000 uomini. Si trattava di una perdita enorme, pari a quasi il 10% della nostra popolazione maschile adulta (esclusi gli schiavi neri, pochi dei quali ebbero l’opportunità di arruolarsi come soldati). In termini relativi, le nostre perdite nella Guerra Civile furono superiori alla terribile perdita di 460.000 soldati italiani durante la Prima Guerra Mondiale, e pari alle perdite subite dalla Francia in quella guerra.
Sulla scia della nostra guerra avevamo bisogno, tra le altre cose, di immigrati, e un gran numero di immigrati cominciò ad arrivare negli Stati Uniti. Persino negli anni Settanta dell’Ottocento, tuttavia, l’afflusso di persone dall’Italia rimase limitato, circa diecimila all’anno. Poi il numero iniziò a crescere rapidamente. Stimiamo che tra il 1880 e il 1920, quattro milioni di italiani giunsero negli Stati Uniti. Molti, o la maggior parte di loro, arrivarono perché le condizioni non erano migliorate per loro in Italia dopo il 1870. Speravano di trovare in America la terra promessa della felicità e della prosperità. Ma, a dire il vero, pur sapendo lavorare sodo, molti di loro non avevano le competenze che avrebbero potuto permettere loro di prosperare, e si ritrovarono oggetto di crudele discriminazione, come era successo agli immigrati dall’Irlanda, in particolare, prima di loro.
L’Archivio Storico Diplomatico di Roma conserva una serie di resoconti sconvolgenti, redatti dagli ambasciatori italiani a Washington, sui linciaggi – torturati, impiccati o bruciati vivi – di cittadini italiani da parte di folle inferocite nel nostro Paese. Diversi sono stati i casi infami, il più noto dei quali è quello degli undici italiani uccisi da una folla a New Orleans nel 1891.
Ci sono volute due o tre generazioni perché gli italoamericani ottenessero i successi negli affari, nel governo, nella scienza e nelle arti che conosciamo oggi: personaggi come i giudici Samuel Alito e Antonin Scalia della nostra Corte Suprema, o Leon Panetta, che fino a poco tempo fa era il nostro Segretario alla Difesa. Ci sono anche successi locali che potrebbero essere meno noti. Ad esempio, nelle zone montuose del Colorado, dove trascorro metà dell’anno, molti dei nostri allevatori più prosperi sono nipoti di italiani poveri che andarono in Colorado a lavorare per salari bassi nelle miniere di carbone.
Vorrei concludere qui e vedere se avete domande a cui potrei rispondere. Spero solo di avervi raccontato, nel mio intervento, alcune cose che non sapevate sui legami tra America e Italia, legami che si svilupparono così lentamente nei secoli successivi a Colombo e Verrazzano, e che sono così importanti oggi.
American Diplomacy è la pubblicazione originale di quest’opera. L’autorizzazione alla ripubblicazione è concessa liberamente, con citazione e link ad American Diplomacy.

BIOGRAFIA DEL GARIBALDINO WILLIAM BAILEY
William nacque a Holborn, figlio di William e Sarah. Fu battezzato nella Great Queen Street Chapel, a Camden, il 31 marzo 1850. Sua madre sposò James Hardiman nel 1847, dopo la morte del marito. Nel 1860, William era in Italia a combattere per Garibaldi. Due anni dopo, era in Australia a lavorare a Rockhampton. William sposò Eliza Whiffen nel Queensland, in Australia, nel gennaio 1866 ed ebbero sette figli, alcuni dei quali rimasero in Australia.
Dal Brisbane Courier:
Con la morte del signor William Henry Leighton Bailey, avvenuta in Inghilterra il 14 settembre all’età di 88 anni, è scomparsa una figura di spicco nei primi circoli giornalistici australiani. Nato in Inghilterra, il defunto signor Bailey emigrò in Australia, dove intraprese la carriera giornalistica. Entrò in contatto con la Press di Rockhampton e in seguito, con l’avvento del giacimento di Palmer, si trasferì a Cooktown, dove fondò l'”Herald”. Lo liberò nel 1878 e si trasferì a Sydney. Dopo la scoperta del giacimento aurifero di Temora (Nuovo Galles del Sud), fondò un giornale lì e in seguito fondò il “Sunday Times”, il primo giornale domenicale di Sydney.
Dopo qualche tempo tornò in Inghilterra, ma continuò a interessarsi da vicino alle vicende australiane e, durante il suo soggiorno, scrisse molta prosa e versi. Il defunto signor Bailey era in costante contatto con amici in Australia, e in particolare con il signor William Lees, a Brisbane. Nella sua pubblicazione, “A Journalist’s Memories”, il generale Spencer Browne si riferisce al defunto signor Bailey come segue: “Ero andato a Cooktown per lavorare come scrittore per il signor William Leighton Bailey, proprietario e direttore dell’Herald. Ora mi sembra una circostanza piuttosto lusinghiera che, dopo una o due settimane, il lavoro editoriale sia stato effettivamente, se non solo nominale, affidato a me. Il signor Bailey era un uomo straordinario. Se si potesse immaginare una Bond Street tropicale, si direbbe che ogni giorno si faceva confezionare abiti lì. Il suo abito era immacolato; la sua casa – una casa generosamente ospitale – era dotata di ogni raffinatezza. Era un lettore, un erudito e un profondo conoscitore dell’arte.
Nella musica eccelleva. La sua era una delle voci tenorili più meravigliose che abbia mai sentito – e ne ho sentite tante, e mi è sembrato straordinario che si fosse perso una carriera operistica. WHL Bailey, senza il suo monocolo, sarebbe stato uno shock tanto grande quanto se si fosse presentato in costume da bagno. Conosceva tutti, tutti lo conoscevano, eppure era solitamente riservato. Per molti aspetti era esotico. C’erano molti uomini splendidi, colti e di buona educazione a Cooktown e dintorni, ma il direttore e proprietario del principale giornale aveva naturalmente, e soprattutto, i modi grandiosi. Non molto tempo fa, quando ero presidente del Queensland Institute of Journalists, il presidente del New South Wales Institute visitò il Queensland, il suo stato natale.
Anche lui era un certo Leighton Bailey, figlio del mio vecchio capo a Cooktown. Lo intrattenevamo qui, e sembrava che ci fosse una trasposizione di periodi. Quando Bailey del “Sydney Evening News” parlava, potevo chiudere gli occhi e sentire suo padre parlare, a distanza di anni, di qualche punto importante sulle comodità del giornalismo. Un altro giornalista e io acquistammo l'”Herald” e la sua attività, ma arrivarono i tempi duri, e temo che l’accordo non fu soddisfacente per il venditore. Bailey, senatore, aveva una famiglia numerosa, ma suo figlio a Sydney è l’unico che abbia visto dai tempi di Cooktown.
Eliza morì nel maggio del 1906 e fu sepolta nel cimitero di Acton. L’8 settembre dello stesso anno, William sposò Jessie Mary McManus nella chiesa di St Dunstan in the West, a Londra. Jessie era impiegata all’ufficio postale. Il loro figlio John Max nacque nel 1908. La famiglia viveva a Mill Hill e William gestiva un’azienda di importazione di medicinali. Nel 1914, si trasferirono a Worthing, in Highdown Avenue, dove Jessie era la direttrice dell’ufficio postale. John fu mandato alla Steyne School di Worthing. Nel 1922, abitarono al 18 di Heene Road, prima di trasferirsi al 3 di Peak Villas in Ivy Place. William morì il 14 settembre 1929 al 74 di Ripley Road, Worthing. Nessuna successione. Jessie si trasferì a Hendon, ma tornò a Worthing. Morì nel 1944.